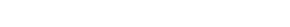Primo Levi, testimone della Shoah
Nei giorni in cui il mondo ricorda la tragedia della Shoah, ripercorriamo la vicenda biografica e letteraria di Primo Levi, di cui nel 2019 cade il centenario della nascita. Di questo grande autore, ormai un classico della letteratura italiana contemporanea, parla Marina Beer in un saggio nella Storia generale della letteratura italiana di Federico Motta Editore, a cura di Pedullà e Borsellino.
Primo Levi, chimico e scrittore
Primo Levi nacque a Torino il 31 luglio 1919. Laureato in chimica, durante la Resistenza si unì a un gruppo di partigiani in Val d’Aosta, ma fu catturato nel 1943. Convinto di potersi salvare, rivelò subito le sue origini ebraiche, una scelta che subito si rivelò drammatica. Fu trasferito dapprima a Fossoli e poi a Monowitz, un sottocampo di Auschwitz. Qui Primo Levi rimase prigioniero fino alla liberazione nel 1945. Nel dopoguerra riprese il suo lavoro di chimico, a cui affiancò quello di scrittore, pubblicando opere apprezzate sia come testimonianza degli orrori nazisti, sia per il loro alto valore letterario. Morì a Torino in circostanze mai chiarite, forse suicida, l’11 aprile 1987.
Una memoria tragica
Scrittura di una memoria tragica, nelle sue forme più alta la scrittura di testimonianza dei lager non è però soltanto una scrittura nata per ricordare e per tramandare, ma una scrittura nata per non dimenticare il passato, talvolta per sopravvivere, infine per continuare a vivere e a comprendere il presente e il futuro.
Con queste parole Marina Beer apre il saggio dedicato a Primo Levi nella Storia generale della letteratura italiana di Federico Motta Editore. In Primo Levi non si può distinguere lo scrittore dalla sua esperienza autobiografica. Nelle sue opere, sia nei romanzi sia nei saggi, ritorna sempre sulle stesse domande, in modo coerente e mai ossessivo. È come un poeta, che in tempi e modi diversi continua a toccare temi già affrontati. La sua opera può quindi essere vista come una forma estrema di poesia, fatta di nuclei finemente cesellati, ciascuno a sé stante eppure strettamente legati. Perché, come disse il filosofo Adorno, «dopo Auschwitz non si può fare più poesia se non su Auschwitz».