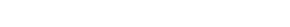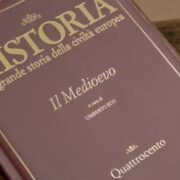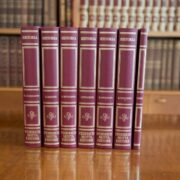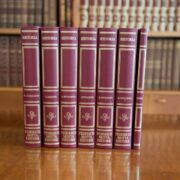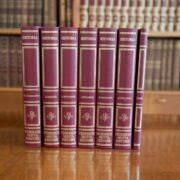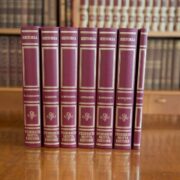Il ritorno dell’ora legale
L’ora legale ritorna: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 le lancette si sposteranno avanti di 60 minuti. Avremo un’ora in meno di sonno, ma in compenso, con l’arrivo della bella stagione, guadagneremo un’ora di luce durante la giornata. Ma come è nata l’ora legale? Parleremo anche del dibattito che la sua adozione continua a generare.
Come è nata l’ora legale
L’Enciclopedia Motta riassume così i vantaggi dell’ora legale:
Le motivazioni sono essenzialmente due: da un lato questa misura dovrebbe consentire risparmi energetici, poiché centrando una parte importante delle attività durante le ore di luce solare si ridurrebbe il ricorso all’illuminazione artificiale; inoltre, i cittadini ne trarrebbero beneficio potendo godere di un maggior numero di ore di luce solare.
Ma come nasce l’idea dell’ora legale? Per capirlo dobbiamo anzitutto fare un passo indietro alla fine dell’Ottocento, quando in alcuni Paesi si avanzò la proposta di adottare un’ora ufficiale. Fino ad allora, infatti, non c’era uniformità negli orari tra le diverse regioni di uno stato e in ogni città si faceva riferimento all’ora locale. I primi a uniformare gli orari furono le ferrovie statunitensi: per evitare di dovere regolare l’orologio a ogni stazione, nel 1883 decisero di adottare un’ora uniforme per ogni regione. Nel 1884, poi, i rappresentanti di 25 paesi riuniti a Washington scelsero come meridiano zero quello di Greenwich, stabilirono la durata del giorno e suddivisero la Terra in fusi orari. Anche se lentamente, molti paesi adottarono questa soluzione.
Restavano però vari problemi di uniformazione tra un paese e l’altro. Nel 1912 a Parigi si tenne la Conferenza Internazionale del Tempo, che trovò una soluzione: inviare segnali orari in tutto il mondo, così da regolare gli orologi su di essi. Per farlo ebbe un ruolo fondamentale il telegrafo. In questo modo, l’uso delle ore locali fu lentamente abbandonato. All’incirca agli stessi anni risale l’adozione dell’ora legale. Nel 1909 l’imprenditore britannico William Willett propose la British Summer Time: sostenne infatti che era possibile recuperare un’ora di luce al mattino semplicemente tirando indietro le lancette durante la bella stagione. Questa strategia fu adottata nel corso della Grande Guerra, allo scopo di risparmiare risorse, e in seguito fu adottata da vari paesi. In Italia l’ora legale è diventata ufficiale nel 1966, dopo che era già stata adottata tra il 1916 e presto abbandonata.
Ora legale: sì o no?
L’adozione dell’ora legale in Italia avvenne nel 1916 e aveva lo scopo di limitare il consumo di luce artificiale. Ben presto però fu abbandonata e solo nel 1966, come abbiamo visto, fu istituita con una legge. Il 22 marzo 1920, infatti, l’adozione dell’ora legale provocò le proteste dei lavoratori a Torino, che invece chiedevano di mantenere l’ora solare. A dare il via allo sciopero fu il licenziamento di alcuni commissari di reparto della FIAT, che avevano rifiutato l’ora legale e di loro iniziativa avevano riportato indietro le lancette della fabbrica. Nel giro di poche settimane la manifestazione portò a scontri con la polizia e si estese a tutto il Piemonte, coinvolgendo circa 500 mila operai. Lo sciopero delle lancette, uno degli episodi più famosi del Biennio Rosso, terminò il 23 aprile con un accordo.
In seguito, in Italia l’ora legale fu adottata e poi abolita più volte. L’esempio dello sciopero delle lancette, però, mostra come la sua introduzione sia da sempre al centro di dibattiti. Lo scopo di questa soluzione è sfruttare meglio le ore di luce durante il giorno, così da risparmiare corrente elettrica. I critici però sostengono che il cambio dell’ora abbia delle ricadute sulla salute: molte persone, infatti, lamentano un’alterazione del ciclo sonno-veglia nei giorni immediatamente successivi il cambio, e anche alcuni scienziati confermano questi effetti collaterali. Il dibattito è molto ampio, tanto che se ne sono occupate anche le istituzioni europee. Nel 2019 il Parlamento Europeo ha approvato l’abolizione dell’ora legale. Affinché sia effettiva, però, è necessario l’accordo sia del Consiglio sia del Parlamento Europeo.